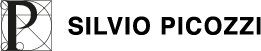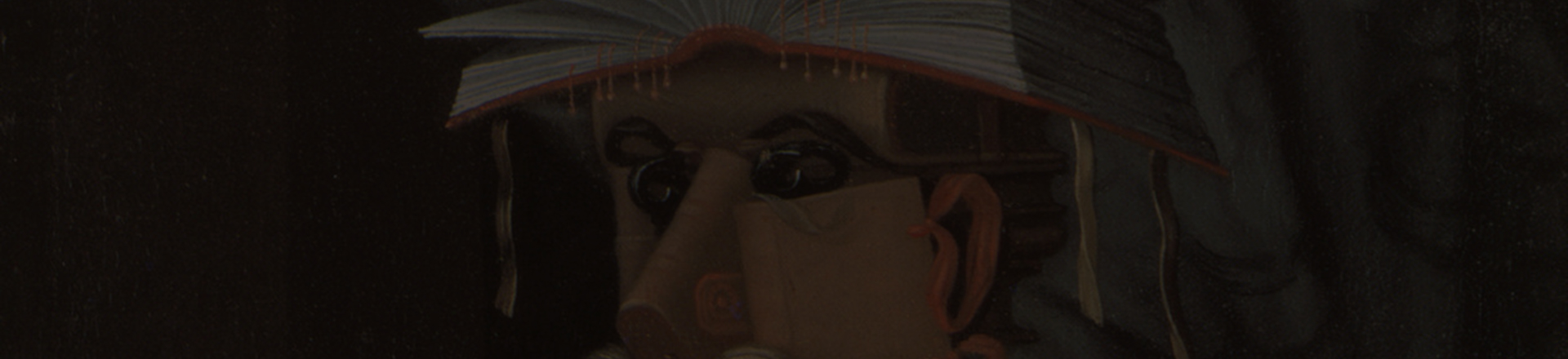
Leonardo da Vinci
Cesare Borgia, detto “Il Valentino” nel 1501 viene nominato Duca di Romagna da suo padre che è il Papa Alessandro VI.
Cesare ha appena conquistato Imola,Faenza, Forlì, Rimini e Pesaro da dove cacciò Giovanni Sforza che a quell’epoca ne era il signore e che era anche suo cognato essendo stato il primo marito della famosa Lucrezia Borgia sorella di Cesare.
Il suo progetto è quello di creare un regno nell’Italia centrale con l’appoggio del potente genitore che non gli fa mancare gli aiuti necessari per finanziare i costi di un esercito efficiente.
Ma il Valentino riesce anche a circondarsi di capaci consiglieri quali Niccolò Macchiavelli, che molto influì sulle decisioni, a volte brutali e scellerate pur di conseguire il risultato, e il grande Leonardo da Vinci che, come ben si sa, impegnò molto del suo genio nello studio dell’arte della guerra e delle relative macchine sia per l’offesa che per la difesa.
La storia ci conferma infatti che Leonardo ebbe l’incarico di visionare tutte le fortificazioni della Romagna e di far apportare le modifiche che ritenesse valide per migliorarne l’efficienza bellica.
Questo progetto impegnò Leonardo per circa due anni e sappiamo che dall’estate al dicembre 1502 Leonardo visita tutte le città della Romagna e delle Marche e riporta su un quadernetto di appunti individuato dalla lettera “L” (il quadernetto misura appena cm 10,9 x 7,2) numerose annotazioni e disegni di estremo interesse perché contiene degli schizzi di fortificazioni e di architetture militari che Leonardo deve aver discusso con Cesare Borgia. Attualmente è conservato presso la Biblioteca dell’Istituto di Francia a Parigi insieme ad altri manoscritti.
Sappiamo che Cesare, entrato in città, ne rimase favorevolmente impressionato ma logicamente la sua attenzione fu attratta dalle caratteristiche della Rocca Costanza e la validità delle soluzioni adottate dai progettisti per rendere la struttura estremamente efficace nella difesa sia attiva, con grande potenza di fuoco su vasti raggi, che passiva con strutture estremamente robuste e praticamente inattaccabili dagli eserciti di quei tempi.


Da una cronaca dell’epoca si legge:
“Addì 28 ottobre dell’anno 1500. Il Duca Valentino entrò nella Rocca di Pesaro, e la volse vedere tutta, e fece chiamare un Pittore e la fece ritrarre in Carta, e la mandò al Papa. Poi 12 Trombettieri si posero sopra la Porta della Rocca nella sommità delle mura e fecero una strombettata e poi fecero una diceria di laude del Duca Valentino.”
La costruzione di Rocca Costanza era terminata da pochi anni, e tutti gli esperti in opere militari avevano espresso giudizi positivi sulle capacità dei capimastri impegnati nell’opera anche perché avevano adottato soluzioni ritenute molto valide. Inoltre erano riusciti ad innalzare una così imponente rocca praticamente sulla sabbia perché, a quell’epoca, il mare giungeva quasi a lambire le mura della fortezza.
Leonardo da Vinci, in un caldo primo d’agosto dell’anno 1502, giunge a Pesaro e nel suo quadernetto riporta questa succinta nota “Dì primo d’agosto 1502…In Pesaro la libreria”.
Da notare che per prima cosa, una volta arrivato a Pesaro, da uomo di grande cultura rivolge la sua attenzione ai famosi incunaboli e manoscritti custoditi nella famosa biblioteca voluta da Francesco Sforza negli ampi locali del Palazzo Ducale.
Per ottemperare agli accordi spattuiti con il Valentino, dedicò nei giorni successivi gran parte del suo tempo allo studio di Rocca Costanza.
Infatti troviamo un foglio del quadernetto L che contiene uno schizzo che riproduce la planimetria, a noi ben nota, di Rocca Costanza, circondato da note e dalle misure rilevate.
L’attenzione di Leonardo si rivolge anche ad un sistema che vede in funzione perché utilizzato per lo scavo del fossato e che nelle sue note battezzò con il termine “tirare di Pesaro”.
Questo metodo di lavoro lo incuriosì tanto da riprodurlo, con la sua magistrale capacità grafica, con le dovute note su un intero foglio oggi contenuto nel famoso “Codice Atlantico” custodito presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano. Ma decise che il sistema visto fosse migliorabile, e sviluppò un progetto per un nuovo macchinario, di grandi dimensioni e con soluzioni per allora rivoluzionarie, che disegnò su un foglio oggi conservato nello stesso codice.
L’avventurosa e fantastica vita di un genio quale Leonardo da Vinci ha ispirato numerosissimi artisti e scrittori ma, in tempi molto più vicini a noi, e precisamente nell’anno 1933, uno scrittore russo, Demetrio Mereskovskij, pubblica un romanzo relativo a tutta la vita del grande genio. Il romanzo ha, a quell’epoca, un notevole successo ma quello che ancora oggi sorprende è l’estrema precisione con cui l’autore descrive i territori percorsi nei numerosi viaggi di Leonardo in Italia.
La nostra curiosità ci ha portato a leggere le sole righe che riguardano Pesaro e, per la precisione, il viaggio da Pesaro a Fano che Leonardo intraprende il 29 dicembre 1502 dove avrebbe dovuto incontrarsi con Cesare Borgia, che l’aveva preceduto di poche ore.
L’autore racconta che Leonardo da Vinci, in compagnia di una guida, “messosi in viaggio di mattina, egli contava di giungere sul posto all’ora del crepuscolo. Ma si scatenò una bufera. I monti si coprirono di neve, le strade diventarono impraticabili. I muli incespicavano ogni momento e i loro zoccoli scivolavano sulle pietre, rivestite di ghiaccio…Calò la notte. Lasciando libere le briglie, i due uomini andarono a casaccio, affidandosi all’intelligenza delle bestie. Scorsero in lontananza brillare un lumicino; la guida riconobbe una grande osteria sotto a Novilara, un paesetto di collina, a mezza strada tra Pesaro e Fano.”….
Dopo aver a lungo bussato al portone dell’osteria, apparve l’oste che, solo alla vista del salvacondotto che Leonardo aveva avuto da Cesare Borgia, propose di cedere la sua stanza al nuovo venuto dato che tutte le camere erano occupate a causa dei tanti viaggiatori che si erano fermati anche loro sorpresi dal maltempo.
“Leonardo entrò nella stanza che serviva da sala da pranzo e da cucina, identica a quella delle altre locande della Romagna, cioè affumicata…con macchie di umidità sulle pareti…con file di cipolle dorate, di salami e di prosciutti appesi alle travi annerite del soffitto. In un immenso camino avvampava il fuoco e sopra, infilato nello spiedo, arrostiva un intero maiale. Nel rosso bagliore delle fiamme, seduti intorno a lunghe tavole, gli ospiti mangiavano, bevevano, gridavano,litigavano e giocavano a dadi, a dama, a carte…”
Dopo aver cenato e trascorsa la notte nel letto del proprietari dell’osteria, Leonardo , al suo risveglio ebbe la sorpresa che “…la bufera di neve si era fatta ancora più violenta. La guida si rifiutò di mettersi in cammino…e Leonardo dovette quindi, per forza, rimandare la partenza all’indomani. Non avendo altre occupazioni, egli si diede a costruire nel camino della cucina uno spiedo automatico di sua invenzione; una grande ruota con palette disposte trasversalmente, messa in moto dall’aria riscaldata nella gola del camino, che a sua volta faceva muovere lo spiedo. – Con un meccanismo come questo,spiegava Leonardo agli astanti stupefatti – il cuoco non corre più alcun pericolo di lasciar bruciare l’arrosto, perché il calore è sempre ugualmente ripartito su tutta la superficie del pezzo che si cuoce; quando il calore aumenta, lo spiedo gira più veloce e quando diminuisce anche lo spiedo gira più lentamente.”
L’invenzione, che stupì il padrone dell’Osteria di Novilara ed i suoi ospiti, non è frutto della fantasia dello scrittore russo ma la ritroviamo effettivamente disegnata da Leonardo e la possiamo ammirare alla pagina 29 r del “Codice Atlantico” conservato presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Leonardo scrisse, in calce al disegno, con la sua caratteristica grafia e rispettando la regola della grafica speculare, la seguente nota:
“Questa è il vero modo di cuocere gli arrosti, imperò che secondo che ‘l fuoco è temperato o forte, l’arrosto si avvolge adagio o presto”.
Una nota che ci conferma come anche un genio come il grande Leonardo mostra un certo interesse al “vero modo di cuocere gli arrosti” e siamo certi che questa particolare attenzione venne suggerita dalla buona tavola delle nostre terre che lo aveva distolto, almeno per qualche momento, dai pensieri e dai progetti di nuove macchine da guerra.